/image%2F4717381%2F20210604%2Fob_6f3e05_18f53632-42d7-417b-8365-34da2ebccec5-l.jpg)
È vero, papà ammirava Mussolini. Ma solo perché vedeva in lui un “Principe” alla Machiavelli. Non aderì mai al regime. Anche se era a Salò insieme a Gentile
Varia fu la vita di Ezra Pound. Sommò intelligenza sublime e operosa, ostentate polemiche (da parte soprattutto di coloro che ne videro un dilettante, anche se di talento) e punizioni terribili. Su quest’uomo — nato a Hailey nell’Idaho — che amò come pochi l’Italia tanto da considerarla una specie di patria culturale, scese una strana notte. Una di quelle notti che non creano legami, ma spavento, che tengono distanti gli uomini dalla vita. Non è facile immaginare cosa provasse in quei momenti e a quale grado di sopportazione fosse giunta la sua resistenza. Ma è con questa immagine senza fiato che vado a trovare la figlia di Pound: Mary de Rachewiltz nel suo castello sopra Merano. È una donna che, nei tratti, rivela un’antica bellezza (ha compiuto in luglio novant’anni). Energica e dolce. Dotata di uno spirito franco e battagliero. Capace di arrabbiarsi, denunciando l’appropriazione indebita che “Casa Pound” ha fatto del nome del padre: «Una vergogna», commenta asciutta.
Ci sediamo nella stanza dove Pound passò alcuni degli ultimi anni della sua vita. Tra i mobili in legno che progettò, alcune copie dell’ Ulysses , dizionari e i libri che erano serviti, in parte, alla stesura dei Cantos , in parte per lavorare su Dante e Cavalcanti. Proprio su Dante sono usciti i suoi saggi: un libro misterioso che Vanni Scheiwiller non fece in tempo a pubblicare e che ora vede la luce, per Marsilio, grazie all’ottima cura di Corrado Bologna e Lorenzo Fabiani.
Vorrei chiederle intanto del suo cognome. Lei non porta quello di suo padre. Perché?
«Era già sposato, e non poté unirsi in matrimonio con mia madre: Olga Rudge. Mi chiamo Maria Rudge. De Rachewiltz è il cognome di mio marito Boris: un personaggio a suo modo singolare. Fu egittologo, incline al mistero. Il padre acquistò questo castello dove, a un certo punto, ci trasferimmo».
Suo padre con chi era sposato?
«Con Dorothy Shakespear da cui ebbe un figlio, Omar. Ma il vero amore fu con mia madre. Un’irlandese testarda, eccellente violinista, innamorata di quest’uomo speciale. Si scambiarono lettere per quasi tutta la vita».
C’è un verso famoso dei Cantos: “Conta solo l’amore, il resto è spazzatura”. Davvero contò solo l’amore?
«L’amore era per lui qualcosa di universale. Non solo l’amore per una donna, ma anche per un poeta, per uno scrittore, per un paese o una città. L’amore era la capacità di vivere con intensità quanto gli accadeva».
E crede che suo padre l’abbia amata a sufficienza?
«Penso di sì. Fu straordinario, anche se intermittente, il nostro rapporto».
Però la sua infanzia non fu facile tra queste due presenze — sua madre e lui — così forti e autonome.
«Non fu facile ma fu felice. Vissi selvaggiamente i miei primi anni in una casa di contadini a Gais in Val Pusteria. A quel tempo la mamma — grazie alle sue competenze musicali — lavorava soprattutto a Siena con il Conte Chigi. Mentre il babbo viveva un po’ a Rapallo e un po’ a Venezia».
Perché suo padre scelse l’Italia come luogo dove vivere?
«Perché amava il bello e il bello era l’Italia, che ritrovava nei mosaici di Ravenna, nella pittura del Quattrocento o nella poesia del Trecento. Amava Venezia. Vi giunse la prima volta da bambino nel 1890».
È giusto ricordare l’attrazione estetica che suo padre ebbe per il nostro paese. Ma ci fu anche l’attrazione politica per il fascismo. Come giudica questo secondo aspetto?
«Mio padre non subì nessuna infatuazione dal regime fascista. Apprezzò viceversa la figura di Mussolini. Tanto che nel 1933 andò a Roma per donare una copia dei Cantos al Duce».
Cosa trovava nel grande dittatore?
«Pur tra gli equivoci che con il tempo si produssero, credo che vedesse in lui quello che Machiavelli vide nel
Principe , cioè la figura in grado di affrontare e risolvere i gravi problemi del paese. Tra l’altro era convinto che Mussolini non volesse la guerra. Ne parlò con George Santayana. Anche lui certo che Mussolini non avrebbe mai dichiarato guerra alla Francia e all’Inghilterra ».
E invece ci finì dentro. Lei come visse gli anni della guerra?
«Ricordo l’ultima vacanza a Venezia. Era l’ottobre del 1940. Con il babbo andammo al Lido. Ogni cosa sembrava spenta. Diversa rispetto agli sfavillanti anni precedenti. Vissi l’entrata in guerra con questa percezione di dissoluzione».
Come reagì?
«Ero disorientata. La mia educazione si era svolta fuori dagli obblighi scolastici che vivevo come un incubo. Amavo leggere quello che il babbo mi consigliava. Un libro che mi affascinò furono Fiabe del Kordofan di Leo Frobenius».
Si conoscevano Frobenius e suo padre?
«Piuttosto bene. Ricordo che nell’edizione tedesca era apposta una dedica di Frobenius. Poi i due si scambiarono lettere. Entrambi mostravano un grande interesse per le civiltà scomparse. Alle tracce che erano sopravvissute: “ Risvegliare i morti” sentivo a volte ripetere. Ossia la capacità di tenere assieme il mito e la storia. Ma sto divagando. Ricordo, sempre a proposito di libri, che quando lessi le memorie di Florence Nightingale decisi che avrei fatto l’infermiera».
Ci riuscì?
«Nell’aprile del 1944 fui presa come segretaria nell’ospedale tedesco di Pocol. Non era esattamente come fare l’infermiera ma entrai in contatto con quel mondo della convalescenza dove il confine tra speranza e disperazione non era del tutto definito».
Che gente si curava?
«Soldati tedeschi vittime anche loro della guerra. Soprattutto cinquantenni: infermi, feriti, malandati, spesso senza denti, ingrigiti nei capelli. Non era un bel vedere. Ricordo, poi, la stanza numero 20».
Cosa aveva di particolare?
«Era detta la stanza dei morituri. Ci portavano i casi disperati. Vidi uno di quei casi. Un aviatore, giovane. Malridotto. Mi scambiò per un dottore. Voleva che fossi io a curarlo. Gli dissi che ero solo una segretaria. Mi mostrò le sue foto. E la medaglia d’argento. Mi raccontò della sorella che studiava medicina a Norimberga. Alla fine riuscii a parlare con l’infermiera che lo aveva in cura e credo che grazie alla sua assistenza quel soldato sia stato uno dei pochi a uscire vivo dalla stanza numero 20 ».
La guerra era persa. I tedeschi in rotta. Mussolini decaduto. E poi il tentativo di fare un nuovo governo, una nuova patria: la Repubblica sociale. Suo padre aderì, perché?
«Forse per un assurdo senso dell’onore e della coerenza. Non era, del resto, capitato qualcosa di analogo a Giovanni Gentile?».
Gentile fu ucciso. Suo padre catturato alla fine della guerra. Lei era abbastanza grande per avvertire tutta la forza della tragedia che si stava consumando.
Quando ne ebbe la certezza?
«Dovrei fare un passo indietro. Quando ci fu l’attacco a Pearl Harbur, da parte dei giapponesi, mio padre restò sconvolto. Poi, l’America dichiarò guerra. A quel punto come tanti americani cercammo il rientro in patria con l’aereo. Ci fu negato. Ci proposero il piroscafo.
Lo consideravano schierato con il nemico.
Ma con il mare infestato di mine e di sottomarini sarebbe stato un suicidio. Poi gli congelarono i conti. In pratica le autorità americane resero impossibile il suo rientro ».
«Per i suoi discorsi alla radio? La verità è che i suoi pronunciamenti, al di là dei toni spesso aspri, erano una denuncia dei poteri forti e della politica del Presidente. Lo accusarono di tradimento».
Che idea si è fatta?
«Pensai che la situazione aveva preso una piega terribile. Ripensavo non solo all’ultima fase, ma anche ai fotogrammi precedenti. Ero tornata a Gais, dove ancora ci si poteva sfamare. Fu qui che lo rividi. Aveva lasciato Roma. Come un fuggiasco. Giunse che sembrava un’altra persona. Aveva i piedi arrossati, martoriati dalle vesciche. Le gambe gonfie. I vestiti sgualciti. Mi si strinse il cuore».
Cosa le dava più fastidio di questa immagine di suo padre?
«Non provavo fastidio. Era tutto comprensibile. Semmai ricordavo l’uomo diverso. Lo spirito ribelle e burlone. Di solito si tende a vedere in Pound solo la
maestosa severità. Non era così».
C’è qualche episodio che le torna in mente?
«La prima volta che io e la mamma arrivammo a Roma, ci portò a vedere Biancaneve e i sette nani . Ci divertimmo tantissimo ».
Gli piaceva il cinema?
«Sì anche quello più popolare. Non disdegnava la commedia americana. Una sera vedemmo un film con Fred Astaire. Quando uscimmo dal cinema il babbo cominciò a ballare il tip tap. Era buffo. Divertente. Sapeva farti ridere e al tempo stesso coinvolgerti in un’impresa. Fu con questo spirito, ad esempio, che egli volle che fossi io a tradurre i Cantos ».
Come avvenne questa investitura?
«Fu abbastanza semplice. Un giorno si presentò con una rivista dove avevano tradotto una parte dei Cantos .
La gettò sul tavolo e disse: vorrei vedere se sai fare di meglio. Intendeva, se potevo tradurre in modo più appropriato. È stato così che ho dedicato parte importante della mia vita a questa impresa».
A proposito di traduzioni, quando suo padre venne arrestato stava traducendo Confucio.
«È vero. Due partigiani — in realtà due ex fascisti, due avanzi di galera che si erano riciclati — seppero che c’era una taglia sulla sua testa. Non gli fu difficile individuare dov’era: sulle colline di Sant’Ambrogio. Vi arrivarono, smaniosi di incassare il denaro. Picchiarono alla porta con i fucili, il babbo era solo in casa. Aprì. Dissero che era un traditore e che lo avrebbero condotto al Comando».
Dove lo portarono esattamente?
«Prima a Zoagli. Da qui a Genova e poi al campo correzionale di Coltano vicino Pisa. Fu difficilissimo rintracciarlo. Alla fine riuscimmo a conoscere la destinazione. Arrivai con la mamma a Pisa. Ci accolsero in una tenda e dopo un po’ arrivò il prigioniero Pound. Disse che erano stati gentili. Non mi parlò allora del posto dove lo avevano rinchiuso. Fu tutto molto penoso. Poi giunse un ufficiale. Decretò con durezza che il colloquio era finito. Il babbo fu portato via».
Cosa accadde?
«Restammo sole, io e mia madre. Angosciate dalla vista di un uomo invecchiato con gli occhi rossi, la camicia e i pantaloni militari troppo grandi, i piedi nudi infilati nelle scarpe senza stringhe. Ci sorrise. Ci abbracciò. E sparì. Solo anni dopo, quando era internato a Washington al St.Elizabeth’s Hospital, mi raccontò cosa era stata l’esperienza pisana, in quella che lui chiamò la “gabbia del gorilla”. A quali sofferenze inaudite fu sottoposto».
Quando tutto questo ebbe termine, cioè circa 14 anni dopo, suo padre decise di tornare in Italia. I testimoni e le persone che lo videro notarono una persona molto diversa.
«Cosa intende?».
Un uomo che aveva scelto il silenzio.
«Era giunta l’età del tacere ».
A questo proposito ricordo un breve filmato televisivo in cui Pasolini nel 1968 intervista Pound. Si nota l’emozione di Pasolini e la distanza quasi remota di suo padre.
«Pasolini era stato tra coloro che avevano non solo approvato ma incitato alla galera. Trovai strano e forse un po’ contradditorio quel ripensamento, quella visita così ossequiosa».
Comunque gli amici che lo difesero e che non l’abbandonarono furono diversi.
«Mia madre fece di tutto per mobilitare le persone che lo avevano conosciuto e amato. Da Hemingway a T.S. Eliot».
Ho visto qui nel Castello in una teca un assegno di Hemingway a suo padre.
«Ah, l’ha notato! Mio padre non l’ha mai riscosso. Millecinquecento dollari che Hemingway aveva messo a disposizione del babbo. Non aveva un rapporto facile con il denaro».
E poi il nome “Pound”.
«Già il nome. È buffo. Homer, suo padre, fu impiegato della zecca».
Come furono gli ultimi anni?
«Sembrava un fiume prosciugato. A un certo punto non voleva più mangiare. Sentiva in lui crescere un senso di inutilità. Venne così il tempus tacendi. Il bisogno di ritrarsi dal mondo».
“Lasciate che un vecchio abbia quiete”, scrisse nei “Cantos”.
«Pensava di aver parlato troppo. Ricordo quella quiete. A volte, con la lentezza dei vecchi, lo vedevo passeggiare con mia madre. Sembravano due sculture di Giacometti. Esili. Enigmatiche. Mute. Due fantasmi usciti dai Cantos che avevano invaso i miei sogni».

/image%2F4717381%2F20220217%2Fob_7d06e9_oleg10.jpg)


/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_b4b700_11-05-will-durant.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_7c878a_honore-de-balzac-011.jpg%3Fwidth%3D465%26dpr%3D1%26s%3Dnone)
/image%2F4717381%2F20231017%2Fob_8dbe8b_progetto-senza-titolo-81.png)
/image%2F4717381%2F20230926%2Fob_f2bc18_ecb6fabeed.jpeg)







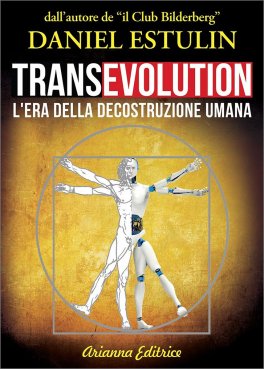









/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_b34bb6_loc-the-peril-of-france-at-the-mercy-o.jpg)
/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_e5d899_architecture-3246665-1920-1540461412.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_b4b700_11-05-will-durant.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_7c878a_honore-de-balzac-011.jpg%3Fwidth%3D465%26dpr%3D1%26s%3Dnone)