/image%2F4717381%2F20220201%2Fob_ffa87b_0-13250.jpg)
Dino Buzzati passava per un cretino. Nella redazione del Corriere della sera era considerato un idiota; anche Indro Montanelli, dirimpettaio di scrivania, lo chiamava Cretinetti. La sua timidezza, la sua indole montanara e militare, il suo “doverismo”, come lui lo chiamava, la sua disciplinata vita di cronista, concorrevano alla nomea. Lui stesso, scrivendo al suo amico Arturo Brambilla, si reputava “rammollito nel cervello”, in preda “all’imbecillità mattutina”; “stabilito definitivamente nella categoria dei fessi”.
Si meravigliava che il Corriere non lo cacciasse, “sono un incapace; non so più come mi tengano…sono lento”, “assolutamente mediocre”, i suoi pezzi, confidava, erano spesso corretti e rifatti, “scorgo sorrisi di compatimento e silenzi imbarazzanti, mi chiudono fuori dalle confidenze” (“Lettere a Brambilla”). Montanelli: “Scriveva lento e faticato con una calligrafia da bambino ancora alle aste, integrata da disegnini altrettanto infantili”.
Poi si accorsero che era un genio e fu Montanelli stesso a segnalarlo a Leo Longanesi, che prima gli aprì le porte di Omnibus, dove Buzzati si firmava Giovanni Drogo e poi gli pubblicò per Rizzoli nel 1940, Il deserto dei tartari. Opera partorita, come è noto, nelle lunghe ore di vuoto delle notizie di cronaca, in redazione, dove “mi tengono in questa inutile attesa”.
Quegli ineffabili Tartari, vanamente aspettati nella Fortezza di via Solferino, erano i Fatti che tardavano a farsi annunciare dagli strilli delle agenzie.
Il 28 gennaio del ’72, giusto cinquant’anni fa, Buzzati lasciava la vita terrena ed entrava coi Tartari e gli Orsi, il Lupo Mannaro e il Gatto mammone, nel bosco metafisico dei trapassati. Aveva 66 anni ma era pronto da anni a inoltrarsi nella boutique del mistero dell’aldilà.
“Qui alla morte è tornato Dino Buzzati che con lei visse dolcemente abbracciato” scrisse Montanelli che all’indomani della sua scomparsa lo descrisse come un antico corteggiatore della morte: “l’ha invocata, l’ha tentata, l’ha cercata”.
Buzzati fu ossessionato dal paragone con Kafka. “Da quando ho cominciato a scrivere – confessò in un articolo sul Corriere – Kafka è stato la mia croce. Non c’è stato mio racconto, romanzo, commedia dove qualcuno non ravvisasse somiglianze, derivazioni, imitazioni o addirittura sfrontati plagi”. Era reputato kafkiano, diceva, anche quando mandava un telegramma o compilava la dichiarazione dei redditi. Scrisse il suo sfogo dopo aver visitato a Praga i luoghi kafkiani, compreso il cimitero, dove trovò sulla sua lapide un corvo che si ripassava le piume, lentamente. Buzzati sostenne che è la vita a imitare Kafka, non lui.
Onirici entrambi, Kafka restò prigioniero degli incubi, Buzzati fu più incline alla versione favolosa dei sogni. Pessimista anche lui, ma salvato dal Corriere dei Piccoli, dove esercitò il suo mestiere insieme alla sua indole puerile e fantastica. La famosa invasione degli orsi in Sicilia, coi suoi testi e disegni, fu il frutto scintillante di quel sodalizio.
Il deserto dei Tartari fu l’opera che più caratterizzò il realismo metafisico della sua narrativa, che poi combaciava con la sua pittura: terso, teso, essenziale, vi fu pure un’eccellente versione in film di Valerio Zurlini.
Nel suo autoritratto si definì “conservatore e militarista”, rispettoso dei principi d’autorità, ordine e tradizione; preciso e metodico, reazionario ma in forma privata, impolitico. Abitò il suo mitico mondo di neve e di sogni, natura e magia, foreste e gnomi, di cui denunciò la scomparsa prima che Pasolini denunciasse la scomparsa delle lucciole: entrambi denunciavano la fine del mondo magico dell’infanzia.
Splendidi furono i suoi racconti; ne ricordo uno, Sette piani, un grottesco noir sanitario ambientato in clinica; bella pure la versione teatrale che ne fece Albert Camus e che Aroldo Tieri portò in tv.
Buzzati si tenne lontano dalla storia; quando se ne occupò, considerò sempre il lato umano, psicologico. Di grande pietas fu un suo articolo sul Corriere del febbraio ’58, dedicato alle lettere ai famigliari scritte dai combattenti della Wermacht nella fatale Stalingrado. “Se tutta la Wermacht fosse stata fatta da uomini simili, mai la storia avrebbe conosciuto una più nobile accolta di gentiluomini e d’eroi (né mai il nazismo sarebbe riuscito a trionfare)”. Ne esaltò la forza d’animo, la “stupenda dignità”, lo “strenuo pudore dei sentimenti”; ascoltavano Beethoven sotto una pioggia di piombo, sapendo di andare incontro alla morte. “Erano dunque uomini anche loro…Anch’essi volevano bene ai prati, alle musiche, alla mamma, alla vecchia casa”. “Non selvagge macchine da guerra, ma uomini, come noi…Si legge, viene da piangere, si fa un esame di coscienza”.
Nei suoi elzeviri tra cronaca e surrealtà, affilata fu la sua critica al conformismo che proibisce le parole e censura automaticamente i testi sconvenienti; davvero profetico… Tra le censure che Buzzati immagina in un altro scritto, c’è pure il divieto della poesia ad opera del “Ministro del Progresso”. Proibendo la poesia, scrive, non ci sarà più “quella rilassatezza d’animo, né quelle morbose eccitazioni, né l’indulgenza ai ricordi, così insidiosi per l’interesse collettivo”; “l’unica cosa che conta è la produttività”, in quel regime che è un mix tra capitalismo e sovietismo. O la satira feroce del giovanilismo presessantottino che induce a dare la caccia ai vecchi per massacrarli di botte; un destino che per Buzzati si sarebbe poi ritorto anche sui giovani, quarant’anni dopo.
L’ultimo suo scritto sul Corriere è dedicato agli alberi che incrocia in treno in velocità: “Non volete rallentare un momento? Non volete spiegarmi il mistero?” E supplicava gli alberi di fermarsi un istante, salvo poi farsi prendere dal dubbio finale “Che per stupidità, viaggiando così, io stia rovinando la vita mia”. Buzzati stava correndo verso la sua morte, con la stupidità sublime e lo stupore infantile che lo avevano accompagnato nella vita.
Autore: Marcello Veneziani

/image%2F4717381%2F20220217%2Fob_7d06e9_oleg10.jpg)


/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_b4b700_11-05-will-durant.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_7c878a_honore-de-balzac-011.jpg%3Fwidth%3D465%26dpr%3D1%26s%3Dnone)
/image%2F4717381%2F20231017%2Fob_8dbe8b_progetto-senza-titolo-81.png)
/image%2F4717381%2F20230926%2Fob_f2bc18_ecb6fabeed.jpeg)







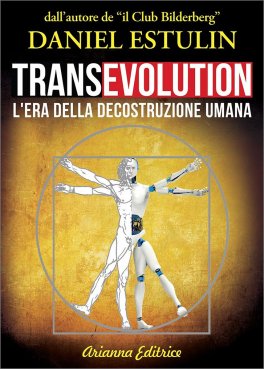









/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_b34bb6_loc-the-peril-of-france-at-the-mercy-o.jpg)
/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_e5d899_architecture-3246665-1920-1540461412.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_b4b700_11-05-will-durant.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_7c878a_honore-de-balzac-011.jpg%3Fwidth%3D465%26dpr%3D1%26s%3Dnone)