/image%2F4717381%2F20231212%2Fob_72d625_giovanni-battista-vico-1200x900-1-e170.jpg)
Se è lecito un ricordo personale, chi scrive si trovava l’anno scorso a Napoli, proprio nel cuore del rettifilo di Spaccanapoli, “all’ombra degli alti tetti e tra l’angustia delle vecchie vie”, e, giunto a San Biagio dei Librai, si mise a sostare sotto la lapide che campeggia a indicare la casa che dette i natali a Giambattista Vico. Al civico 31, ora mestamente sede di una friggitoria, si trovava la minuscola cameretta dove nacque il futuro autore della Scienza Nuova e, come suona l’epigrafe, dettata da Benedetto Croce,
“qui dimorò fino a diciassette anni e nella sottoposta piccola bottega del padre libraio usò passare le notti nello studio, vigilia giovanile della sua opera sublime”.
L’ iscrizione era malamente distinguibile, in quanto deturpata da un invasivo faretto e, nel brulicare del passaggio, nella frenesia del viavai nessuno sembrava prestare attenzione al luogo in cui nacque una delle massime menti della storia del pensiero. Fatto sta che mentre indugiavo a leggere l’epigrafe un vecchietto mi si avvicinò e sorridendo mi disse: “Venite, lì c’è sepolto il papà!”, conducendomi quindi, pochi metri più innanzi, nella chiesetta minuscola di San Biagio dove mi indicò la sepoltura del padre libraio di Vico, Antonio, e dove il piccolo Giambattista era stato battezzato.
Miracoli di umanità quotidiana che sembrano accadere a Napoli più che in altri luoghi!
Nel popolo napoletano albergano una fantasia e una creatività innate che sembrano dare un contrassegno a ogni loro caratteristica, ai loro pregi come ai loro giganteschi difetti, ma, in ogni caso, con un mirabile estro che non si ritrova in nessuna altra città d’Italia e che ancora dà ragione, secoli dopo, al ritratto esattissimo che Goethe dette di esso, cogliendo contro ogni luogo comune l’industriosità del popolo più basso, il suo vivere in una specie di ebbrezza e di oblio di se stesso alimentato dal fatto di vivere sotto la costante minaccia del Vesuvio:
“La terribilità contrapposta al bello, il bello alla terribilità; l’uno e l’altro si annullano a vicenda, e ne risulta un sentimento d’indifferenza. I napoletani sarebbero senza dubbio diversi se non si sentissero costretti fra Dio e Satana”.
Un Genius Loci tutto particolare dimora a Napoli, città dove anche nel degrado e nella miseria palpabile sopravvive, altrettanto cogente, il sentimento innato della musica e della poesia, un’inclinazione verso la dimensione fantastica e, all’ opposto, nelle sue declinazioni più alte, verso la dimensione speculativa. Nel tortuoso viluppo di vie del centro di Napoli si trovano, a distanza di poche centinaia di metri tra loro, il convento di San Domenico dove furono a vario titolo studenti o insegnanti San Tommaso d’Aquino, Giordano Bruno e Tommaso Campanella, le varie abitazioni in cui dimorò Vico, mai allontanatosi da Napoli se non per il giovanile soggiorno a Vatolla, e quel Palazzo Filomarino dove visse dal 1911 sino alla morte Benedetto Croce e nelle cui stanze, secoli addietro, proprio Vico faceva lezione al Principe di Filomarino.
/image%2F4717381%2F20231212%2Fob_0d5fa0_d2e8b007ec-1024x810.jpg)
Singolare che due dei massimi pensatori italiani abbiano entrambi, in circostanze assai diverse soggiornato lì, Vico sempre poverissimo e angustiato dai mille tormenti della vita materiale (la sua vita è forse la più commovente tra tutte quelle dei filosofi), Croce invece protetto dalle fortune di una ricchissima famiglia dell’alta borghesia meridionale. Vite parallele in molti tratti, anche, pur nella distanza antipodale tra le loro condizioni di vita pratiche ed economiche, nella comune radice del loro filosofare da eventi tragici che li segnarono per tutta la loro esistenza.
Vico cadde rovinosamente da una scala quando era ancora bambino, intento a prendere uno dei grossi tomi del padre libraio, e rimase per lunghe ore in stato di incoscienza, sopravvivendo a stento e restando da allora solcato da una vena di melanconia insanabile; la profezia per cui sarebbe rimasto per sempre menomato o privato delle sue facoltà mentali non solo non si avverò ma, anzi, il tragico accadimento fu uno dei pungoli che più lo spronarono alla sua attività di fanciullo prodigioso, di meraviglioso “autodidascalo”.
Croce diciassettenne fu invece coinvolto nel devastante terremoto di Casamicciola del 1883 da cui fu tratto in salvo dopo molte ore trascorse tra le macerie e in cui perdette entrambi i genitori e la sorella, restandone fracassato nello spirito e nel corpo e portandolo a nutrire negli anni giovanili incessanti pensieri di suicidio che riaffioreranno a più riprese anche dopo, nelle pagine private dei Taccuini di lavoro. Tragedia che, nella sua terribilità, lo portò progressivamente a scuotersi dalle pure ricerche erudite per avviarlo invece sulla strada erta della grande speculazione, all’interrogarsi sul nostro essere nel mondo e a cercare di risanare quella fortissima angoscia esistenziale con la catarsi del pensiero, con la gioia impareggiabile dello sforzo di chiarificazione razionale.
In quel ristretto perimetro di vie descritto poc’anzi si trova la più alta concentrazione del nostro pensiero filosofico, il massimo ricettacolo della gloriosa tradizione speculativa italiana. In esso si svolse pressoché tutta l’esistenza terrena del Vico, la cui parabola portentosa è stata ora narrata con commossa partecipazione e spirito schiettamente antiaccademico da Marcello Veneziani nel suo Vico dei Miracoli, recentemente pubblicato da Rizzoli.
È addirittura degli anni ’30 la ricostruzione di Fausto Nicolini de La giovinezza di Giambattista Vico, composta con infinita affezione per l’oggetto del suo studio e con infinita dottrina, trasmettendoci vivo e pulsante il percorso di formazione del genio napoletano. Ma la monografia di Nicolini, ancorché magistrale e appassionante, serba quel sentore di archivio che si indirizza giocoforza agli specialisti e si sentiva la necessità, pienamente espletata dal libro di Veneziani, di una nuova narrazione della vita e del pensiero di Vico, riservata non ad accademici e professori ma a chi sia genericamente e universalmente curioso della parabola dell’umano pensiero.
Un modello che nella letteratura italiana vanta pochi precedenti, tutta ingabbiata come essa è sempre stata nelle maglie della pedanteria, dello specialismo settorializzato, e avvolta ad arte nella più ispida terminologia filosofica. Esempi scintillanti e in totale controtendenza furono le biografie filosofiche scritte da Anacleto Verrecchia su Nietzsche, su Schopenhauer e su Giordano Bruno, non considerate con l’ammirazione che meritano e anzi spesso volutamente obliterate proprio perché Verrecchia fu sempre un outsider estraneo all’accademia e anzi di essa ferocemente nemico. Qualcosa dello stile scanzonato e del brio di Verrecchia permane in questo libro di Veneziani, dove si avverte in ogni pagina come Vico non sia per lui sterile pretesto per baloccamenti concettuali ma materia viva; e alla vita il libro attinge costantemente, così come intinto nella vita è sempre il pensiero dei grandi filosofi di Napoli, come scaturito dall’anima e dal pulsare della città anche quando si inerpica nelle più alte vette dell’astrazione.
Assai suggestivo è il paragone che Veneziani traccia tra la Scienza Nuova e la Divina Commedia, volendo significare che come nel poema dantesco Vico compie un cammino ascendente dalla storia al cielo, dalla mente umana alla mente divina sotto lo sguardo protettivo della Provvidenza, quella Provvidenza che Vico chiama “mente eterna ed infinita che penetra tutto e presentisce tutto” e “spesso contro ogni loro proposito, dispone a un fine universale, per la quale, usando Ella per mezzo quegli stessi particolari fini, li conserva”.
Eterogenesi dei fini, per dirla con linguaggio moderno!
E di eterogenesi dei fini si trattò anche per le molte traversie vissute da Vico della sua esistenza e qui puntualmente ripercorse.
L’angusta cameretta cui accennavamo misurava tre metri per sei e il giovane Giambattista era costretto a cucinare per strada su un fornello (la famiglia contava altri sette fratelli) e a studiare nottetempo, malaticcio e precocemente segnato dalla tubercolosi (“Mastro Tisicuzzo” fu poi sprezzantemente epitetato da un suo livoroso avversario, il Valletta). In quelle circostanze miserande Vico accumulava una formidabile cultura nei più vari campi dello scibile e ideava il primo nucleo della Scienza Nuova, opera prodigiosa e commovente che ha, a ripensarci, dell’inverosimile: veramente, e non per enfasi retorica, Vico dei miracoli!
Né più facile fu la sua vita successiva, costretto a sbarcare il lunario con il misero stipendio della sua cattedra di retorica e a mantenere la numerosa prole cui dette i natali, ben otto figli a sua volta, di cui uno scapestrato che fu costretto a denunciare alla giustizia per poi pentirsene immediatamente. Tra “lo strepito de’ suoi figliuoli”, circondato da una napoletanissima e chiassosa famiglia, sempre travagliato dalle necessità materiali e di malferma salute, Vico concepiva la sua opera immortale nel più assordante silenzio e nella più completa sordità dei contemporanei, che giunsero spesso a deriderlo e a ritenerlo incomprensibile o matto. Quando egli si spense, nel 1744, quasi completo fu il silenzio che accolse la sua dipartita e Vico morì sostanzialmente dimenticato.
Quella Scienza Nuova cui egli profetizzò innumerevoli commentatori nei secoli a venire e che resta uno dei capidopera della filosofia di ogni tempo (e che è insieme libro di antropologia e di psicologia comparata) rimase del tutto ignorata e incompresa sino all’epoca romantica, quando non a caso a riesumarla e a coglierla nella sua immensa grandezza fu lo storico di più ampio respiro della Francia dell’Ottocento, Jules Michelet. I “corsi e ricorsi storici” finalmente restituivano a Vico la sua piena statura di gigante del pensiero. La consonanza tra lo spirito romantico e le germinali intuizioni vichiane era matura per essere portata alla luce ma ancora il nucleo concettuale dell’opera non era pienamente compreso e sviscerato e il concetto vichiano della storia finiva per confondere le sue acque con quello della generica “Filosofia della Storia”.
/image%2F4717381%2F20231212%2Fob_6b2e6b_9788817182942-92-1000-0-75.jpg)
Veneziani pone Vico al crocevia del pensiero italiano, partendo dalle radici profonde della cultura mediterranea, greca, latina e cristiana, quella cultura che il pensatore napoletano aveva genialmente lumeggiato nell’opera anticipatrice della Scienza Nuova, il De Antiquissima Italorum Sapientia. Ma la portata vera del pensiero di Vico sarà davvero compresa solo con il De Sanctis prima e con gli scritti di Croce e di Gentile poi, ancora oggi le pagine di più alta densità speculativa tra le innumeri dedicate al nostro filosofo.
La grande monografia crociana su La filosofia di Giambattista Vico data al 1911 e resta tuttora l’opera magna della sterminata bibliografia vichiana, l’opera che meglio ha posto in risalto Vico come fondatore del concetto moderno della storia e come primo scopritore della scienza estetica modernamente intesa. Vico veniva considerato come né più e né meno che come il diciannovesimo secolo in nuce, come uno straordinario e incompreso precorritore di una visione dell’estetica e della storia elaborata solo in età romantica. Molto da allora si è scritto in ogni contesto, facendo di Vico anche un anticipatore della sociologia o dell’esistenzialismo o di alcune risultanze delle moderne scienze cognitive, o sospingendo Vico nell’ orizzonte più generale della storia delle idee.
Isaiah Berlin esplorò magistralmente le consonanze e le differenze tra Vico e Herder e l’inserirsi di Vico nel contesto più generale della storia del pensiero ma tale tipo di ricerca annacqua talvolta l’esplorazione del nucleo concettuale più intimo e astruso dei filosofi. La filosofia si riversa nella Kulturgeschichte e si svuota talora del suo stesso contenuto speculativo più autentico, cui va invece incessantemente ricondotta. Platone fu il filosofo che maggiormente segnò Vico, sicuramente più di Tacito e di Bacone, da lui eletti a suoi grandi numi tutelari. La sintesi tra il divenire storico e l’eterno mondo delle idee fu proprio l’ assunto massimo della sua arduissima, vertiginosa Scienza Nuova, opera in cui la difficoltà concettuale si sposa ad uno stile aspro, talora pietroso, di grandissimo fascino nel suo lampeggiare intermittente tra periodi quasi tenebrosi. La “Storia ideale eterna” si esplica nel divenire e nella contingenza appunto come Provvidenza, come ragione trascendente.
Vico tentò con un immane sforzo la conciliazione dei due piani della metafisica e dello storicismo empirico, lo stesso tentativo ripreso appunto da Croce nel senso dello storicismo assoluto, della riduzione senza residui della filosofia e della storiografia in una circolarità perenne .
E tuttavia la storicizzazione completa della filosofia si rivela un’illusione, un naufragio della speculazione, perché sia in Vico che in Croce (nel primo consciamente, nel secondo come momento aporetico del suo sistema) la storia viene sempre risospinta verso la metafisica, verso una dimensione non solo storica ma metastorica: la storia ideale eterna si libra senza posa sopra la storia materiale e la datità.
/image%2F4717381%2F20231212%2Fob_b59cee_35501-1.jpg)
La piena coincidenza tra filosofia e storia della filosofia postulata da storici anche sommi come il nostro Eugenio Garin in ultimo rischia proprio di ridurre la storia del pensiero a un inanellarsi di concetti e categorie puramente storicizzati smarrendo però le condizioni trascendentali di essi.
Nel caso di Vico, padre dello storicismo moderno, è tuttavia impossibile ricondurre a puro immanentismo il suo orizzonte di pensiero e l’interpretazione che ne dette Croce in tale senso non è percorribile fino in fondo. Nello stesso Croce, sia come interprete vichiano che come filosofo originale, riaffiorano incessantemente tematizzazioni di ordine metafisico e trascendenti l’orizzonte tutto sommato angusto dello storicismo, come nel problema dell’inizio del pensiero, della prima categoria, che a un certo punto pare non essere più l’intuizione aurorale ma proprio la “vitalità”, la vitalità cruda e verde che da slancio gioioso sembrerà sempre più declinare verso il disvalore ed il male.
Quanta stretta parentela tra i “bestioni” dell’Età eroica aggirandosi per “la gran selva della terra” tratteggiati da Vico e questa tumultuante e perturbante “vitalità”!
Un pensatore dell’acume di Enzo Paci colse il trait d’union e la non necessaria incompatibilità dello storicismo e dell’esistenzialismo proprio nel configurarsi della vitalità come prima categoria e in Vico scorgeva la contraddizione e la lotta tra due anime, una pessimistica e intrisa di umori lucreziani (la tetrissima canzone giovanile Gli affetti di un disperato) e una invece vitalistica mente protesa verso l’umano progresso e l’umana perfettibilità.
Polarizzazione perenne tra la bestialità e l’eroicità che sempre ci accompagna, soprattutto in tempi come i presenti che Vico avrebbe definito della “barbarie ricorsa”.
Alessio Magaddino

/image%2F4717381%2F20220217%2Fob_7d06e9_oleg10.jpg)


/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_e5d899_architecture-3246665-1920-1540461412.jpg)
/image%2F4717381%2F20230207%2Fob_9b5e1a_cover10.png)
/image%2F4717381%2F20230206%2Fob_e47398_cover1.png)
/image%2F4717381%2F20220322%2Fob_c9b6ee_satanismo10.png)







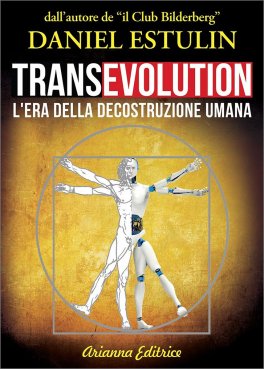









/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_b34bb6_loc-the-peril-of-france-at-the-mercy-o.jpg)
/image%2F4717381%2F20240206%2Fob_e5d899_architecture-3246665-1920-1540461412.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_b4b700_11-05-will-durant.jpg)
/image%2F4717381%2F20231215%2Fob_7c878a_honore-de-balzac-011.jpg%3Fwidth%3D465%26dpr%3D1%26s%3Dnone)